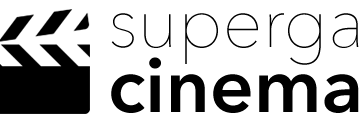C’è un fattore comune che avvicina tutti gli spettatori al termine di un film di Quentin Tarantino; un fattore che esula dall’intera visione del film – o prodotto cinematografico, a volerlo intendere più in un’accezione generale – e che si concentra sulle ultime battute dello stesso, quasi come se due ore fossero l’antipasto per un concentrato di soli dieci o venti minuti. Questo fattor comune è la capacità di rimanere estasiati e sconvolti, nonostante ciò che si sta osservando sia palesemente falso o, nella migliore delle ipotesi, manovrato a dovere e vestito di cinematografia. Questa sensazione di sorpresa, di sconvolgimento, la si avverte nel massacro collettivo di Reservoir Dogs o nell’esplosione del cuore con le cinque dita, con cui il famigerato Bill trova la morte. E, ancora una volta, Tarantino – giunto ormai al suo nono film – riesce a ricreare una situazione ideale, lasciando estasiato lo spettatore di fronte all’impensato finale. Su queste basi C’era una volta a… Hollywood è uguale e meglio di tutti gli altri film del regista e sceneggiatore statunitense.
Il cast eccezionale di Once Upon a Time in… Hollywood
Ciò che, prima di ogni altra cosa, colpisce è la presenza di un cast eccezionale che riesce a colmare ogni possibile lacuna, dando valore ad ogni singolo personaggio. A dire il vero, quel valore di cui si fa cenno sembrerebbe essere intrinseco, non soltanto per i nomi che prendono parte al nono film di Quentin Tarantino, ma anche per quanto espresso e quanto voluto dagli stessi.
A leggere di nomi come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino sembrerebbe cosa fatta, lavoro facile: avere con sè l’élite della cinematografia è il sogno di ogni regista e, contemporaneamente, il suo incubo. In Once Upon a Time in… Hollywood, però, accade quel qualcosa di magico che indirizza tutto nel verso giusto, lasciando intendere che il prodotto cinematografico – diversamente da ciò che viene ampiamente mostrato nel film di Tarantino – non è cosa da poco, non è esigenza monetaria, non è questione di vita o morte.
Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che nel film interpretano rispettivamente Rick Dalton e Cliff Booth, decidono volontariamente di ridursi l’ingaggio, non gravando su un budget che, seppur cospicuo (quasi 100 milioni di euro stanziati per la realizzazione del film), non sarebbe altrimenti in grado di coprire ogni spesa; Margot Robbie (Sharon Tate) viene ufficializzata soltanto alla fine, nonostante fosse il primo ingaggio di Tarantino. E non mancano i nomi di Al Pacino (Martin Schwartz), Emile Hirsch (Jay Sebring), Margaret Qualley (Pussycat) e Austin Butler (Tex Walton).
Recensione di C’era una volta a… Hollywood
Venendo al fulcro della questione, C’era una volta a… Hollywood potrebbe essere pensato in qualsiasi modo e secondo qualsiasi accezione e, in nessun caso, si commetterebbe un errore nel definirlo. Pensare a questo film come un concentrato di nulla non è del tutto sbagliato, così come è corretto identificarlo come il prezioso omaggio di Tarantino a se stesso, alla sua cinematografia, alle sue passioni, alla sua ideologia di cinema che batte la realtà.
I 160 minuti totali di C’era una volta a… Hollywood si strutturano attraverso la narrazione quotidiana, e a tratti quasi insensata, di un attore un tempo fallito, ora costretto ad accettare parti da cattivo solo per fare denaro, e della sua controfigura. In molti momenti del film non si capisce dove Tarantino voglia andare a parare, chi sia il protagonista della vicenda, quale sia la trama da seguire o a cui appassionarsi. In alcuni momenti, addirittura, si potrebbe pensare di non star vedendo nulla, se non una serie di assurde citazioni.
C’è però un sottile filo che collega tutto, e che difficilmente può essere notato se non si conosce il trascorso tarantiniano, né gli intenti di un film che parla di ciò che non mostra, e mostra ciò di cui non parla. Diversi mesi prima dell’ufficializzazione di Once Upon a Time in… Hollywood si erano moltiplicate le indiscrezioni riguardanti la possibile realizzazione di un film di Tarantino sulla famiglia Manson; conoscendo i trascorsi del regista statunitense, che di velature non si serve mai, il prodotto che tutti hanno immaginato sembrava essere sfumato in un nulla di fatto, in uno dei tanti progetti che non hanno trovato forma né concretizzazione.
La vittoria del cinema di Tarantino contro la realtà
La famiglia Manson viene ridotta, all’interno del nono film di Quentin Tarantino, a poche ma significative scene. Scene che in un primo momento si osservano con indifferenza o senza quella concentrazione necessaria che porterebbe a ricavarne una trama totale. Come già sperimentato all’interno del suo primo lungometraggio, Tarantino inserisce un dettaglio che anticipa il finale ma che, in 9 casi su 10, sembra non avere valore agli occhi dello spettatore: in Reservoir Dogs era stato un piccolo dettaglio arancione a chiarire chi fosse l’infiltrato prima della effettiva ammissione di Mr. Orange, in C’era una volta a… Hollywood è un semplice uomo che si presenta in casa Polansky, chiedendo del vecchio proprietario di casa.
Quell’uomo, che alla fine del film si rivelerà essere Charles Manson, è il fulcro dell’intera pellicola di Quentin Tarantino. Si spiegano soltanto alla fine i climi sinistri che Cliff Booth affronta al Ranch (un vecchio set cinematografico) e quella costante e inspiegabile sensazione di angoscia che colpisce lo spettatore in scene apparentemente tranquille.
Il trionfo del nono film di Tarantino c’è negli elementi a lui più cari: lo splatter irrompe sulla scena spezzando irreversibilmente l’equilibrio della trama, il massacro la fa da padrona e il male viene non solo sconfitto, ma anche ridicolizzato. Quello che nella realtà è stato l’omicidio di Sharon Tate diventa, nel film di Tarantino, “i cazzi del demonio”, secondo un’affermazione pronunciata da Cliff Booth. E così, Quentin Tarantino si permette di cambiare il corso della storia come vuole, come se fosse autorizzato a farlo: l’aveva già fatto in Bastardi Senza Gloria, lo ripete nel suo nono film; quasi come se la cinematografia fosse solo sospensione dell’incredulità, quasi come se un film fosse il rifugio della propria visione – distorta, ma non per questo peggiore – della realtà.