Oscar 2023: i peggiori ed i migliori film
di Redazione
18/02/2023

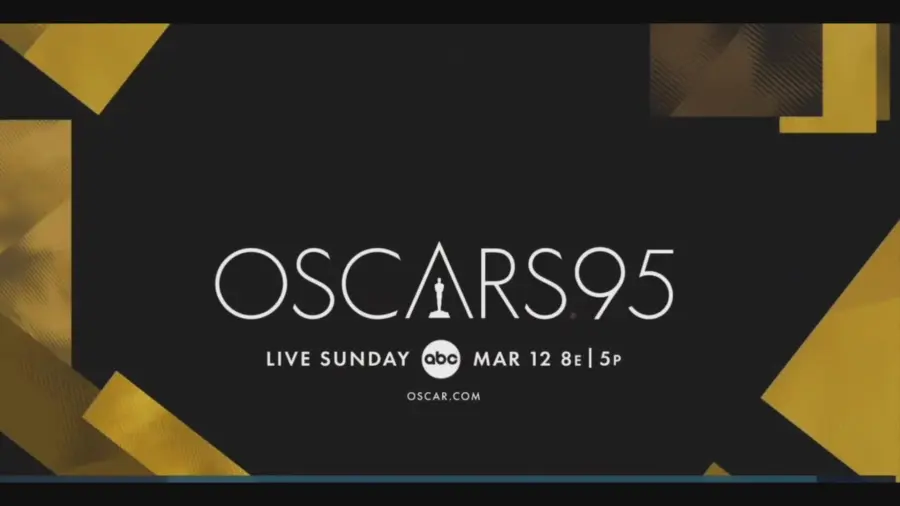
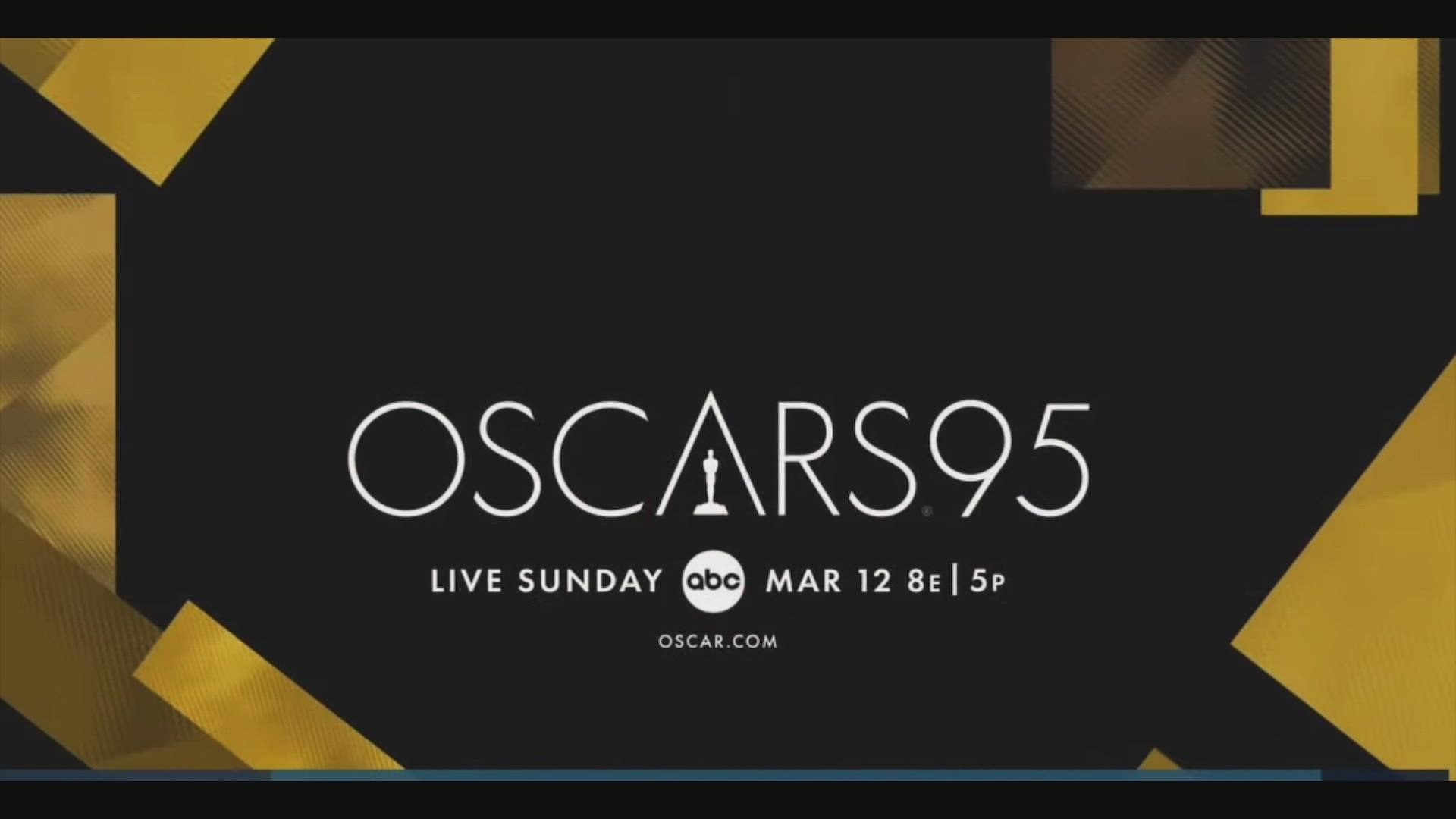
Gli Oscar 2023 sono previsti a Los Angeles il prossimo 12 marzo, e i film nominati sono tanti e non mancano le discussioni a riguardo. I più candidati sono stati Everything Everywhere All at Once, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Gli spiriti dell'isola, Elvis, The Fabelmans, Top Gun: Maverick. Ma quali sono i migliori e quali i peggiori? Il dibattito è ormai aperto dalla comunicazione delle nomination, ed è giusto tirar fuori una classifica in ordine qualitativo, secondo i parametri personali di chi scrivere (ovviamente). Verranno considerati dei parametri nella seguente classifica: i film devono avere più di una nomination, sono esclusi quelli non visti: Women Talking, ancora non distribuito in Italia, e Triangle of Sadness, non disponibile in streaming legale e in home-video in Italia; stesso discorso per Living.
Oscar 2023: quali sono i peggiori ed i migliori film candidati?
Ci sono dei film di indubbia qualità ad essere presenti nelle varie nomination degli Oscar, ma altri, tra delusioni e incomprensioni, hanno qualcosa di poco convincenti. Quanto segue è una classifica personale, e la qualità stabilite rispecchiato dei dati d'analisi e argomentazioni individuali. Ecco quali sono i peggiori ed i migliori film candidati agli Oscar 2023, cominciando dal peggio a salire.
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Film di guerra tedesco ispirato all'omonimo romanzo best seller di cui è la seconda trasposizione. Niente di nuovo sul fronte occidentale è a tema, il ché non è necessariamente un limite, ma i suoi problemi sono grossolani e si evincono dall'incipit. La spettacolarizzazione della guerra, l'esasperata estetica dei corpi, la colonna sonora inspiegabilmente pop con i suoi suoni bassi e angoscianti, sono tutti elementi che rendono la guerra contemporanea e quasi da "pop art" per tali scelte. La recitazione è calcata continuamente, perché lo spirito del film è mostrare la natura entusiasmante vista dagli occhi dei giovani soldati tedesco in procinto di partire per la missione nel 1917. Gradualmente, tramite dialoghi banali, viene fatto didascalicamente preste quanto la guerra sia in realtà diversa da quanto atteso, terribile e logorante.
Peccato che questi aggettivi non appartengono agli elementi profilmici bensì a quelli filmici: una fotografia che esaspera le tonalità presenti quali grigio e giallo; il trucco gioca furbamente con fango e polvere, comprendo i volti; la regia è sgraziata, statica quando non deve e dinamica nei momenti meno opportuni. Scenografia piuttosto basilare e perlopiù presa di pari passo da 1917, film di Sam Mendes. I temi portanti e ridondanti sono la fame e la mancanza di donne per i soldati, banalizzando così le atrocità subite. Dovrebbe essere un film sulla guerra di trincea, ma quest'ultima è presente relativamente. Film semplicemente con un incipit di cattivo gusto, tempi enormemente dilatati, discorsi politici e di battaglia praticamente inesistenti. Il peggior film candidato agli Oscar 2023, è anche uno dei più nominati.
The Whale
Trucco digitale e prostetico che ingrassa a dismisura Brendan Fraser, ma ad essere fuori misura è il film stesso, basato su una pièce teatrale. Decisamente troppo lungo, didascalico e sregolato. I dialoghi lasciano spaesati lo spettatore per contraddizioni, scricchiolii vari, retorica abbondante. Lo stesso Fraser, tutt'altro che eccellente, calca troppo la mano nella recitazione: piange, urla, ride, ma a mancare sono le tonalità, le sfumature espressive. Il finale è telefonato, forzatamente commovente, ma i dialoghi sono la parte peggiore, siccome sono frasi fatte messe insieme.
L'arte finalizzata al far piangere prende vita per quasi due ore di film, appesantendo il racconto e annichilendo il senso dell'opera stessa. La sceneggiatura non originale non ce la fa ad essere candidata nella cinquina, l'attore protagonista e l'attrice non protagonista si, oltre al trucco.
Everything Everywhere All at Once
Nel peggio ci finisce il candidato numero uno ai prossimi Oscar 2023. Una posticcia opera manierista che gioca a mescolare genere per 2 ore e 20 raccontando un fattarello familiare. La ridondanza regna sovrana, ma il nocciolo è una risolvibile diatriba tra Evelyn (Michelle Yeoh) e la figlia, oltre che i gravi problemi finanziari dovuti alla gestione della lavanderia.
Le citazioni abbondano ma non hanno uno scopo narrativo, servono solo a creare intrattenimento spicciolo con coreografie corali riempite di espedienti puerili e ineleganti. I vari multiversi annullano ogni volta quanto visto poco prima: chi muore, non muore; chi parla, non ha parlato davvero; chi fa, non fa. Allora il senso qual è? Tutto è ridotto al bagel gigante e al discorso chiarificatore tra Evelyn e la figlia, piuttosto scontato, retorico e banale.
Babylon
"Vorrei, ma non posso". Questo il mantra di Damien Chazelle che non convince appieno l'Academy con il suo ultimo film, rilegato ad appena tre nomination. Il regista di La La Land si perde e, nonostante delle prove attoriali di livello e una colonna sonora travolgente con note che richiamano il musical citato, il film si perde in sproloqui derivati da capolavori del calibro di Cantando sotto la pioggia e Viale del tramonto. Come per EEAAO, il discorso è lo stesso: citazioni inutili e tempi dilatati per discorsi già assodati. Almeno in Babylon c'è un'ora buona di tempi comici ben distesi e discorsi meta cinematografici interessanti sulla ricostruzione di un'epoca, soprattutto del passaggio dal cinema muto a quello sonoro.
Il primo blocco nel suo essere grottesco e ben musicato risulta travolgente e divertente, ma le restanti due ore rasentano quanto meno una perdita della bussola, il regista non sa più cosa raccontare. Quando inizia a voler essere un dramma, una commedia demenziale e infine una specie di noir, non se ne comprende il linguaggio, tanto meno l'obiettivo. Il finale è quanto di più sgraziato e banale potesse esserci: una sequenza di montaggio che mette insieme brevi scorsi di film che ripercorrono 100 anni di storia del cinema. Chazelle, preso dalla mania di protagonista per nutrire il suo ego, fa specchiare i suoi protagonisti ricreando scene rigirate a emulare i capolavori sopra citati. Detto ciò, il finale andava bene per un divertente (circa) montaggio da presentare al laboratorio dell'università.
Elvis
Ennesimo biopic tradizionale, ma la delusione è più cocente siccome a dirigere è Baz Luhrmann. L'inizio esteticamente travolgente, fluido e luccicante al montaggio e nella deformazione-creazione dell'immagine, imbastisce una riflessione potenziale sul fumetto contemporaneo e l'iconografia passata, con la possibilità di avvicinare le diverse sfumature del "mainstream" tramite il famoso cantante americano. Elvis è un vero e proprio supereroe in grado di sedurre, di alimentarsi grazie all'amore del suo pubblico. L'incipit è presentato dal voice over del villain, il manager del cantante, il colonnello Tom Parker, ma non si capisce perché adottare tale scelta se non è filtrato tutto dalla sua percezione soggettiva e se sul finale non si sente più la sua voce per lasciare spazio alle classiche scritte in sovrimpressione a spiegare cosa è accaduto dopo la morte di Elvis.
Peccato che, tolto Austin Butler davvero bravo, tutto il resto del cast (compreso Tom Hanks) è sotto tono. I primi quaranta minuti sono ottimi, ma il film gradualmente è in declino e si limita a raccontare velocemente tutti gli eventi o quasi accaduti nella vita dell'icona pop. Non si capisce perché certi discorsi come il ponte che ha rappresentato Elvis per far crollare la segregazione razziale in America, l'idea di supereroe associata a lui, vengono lasciati in panchina per offrire null'altro che il convenzionalismo dei biopic: si racconta velocemente ma in tempi dilatati, che contraddizione. E tra l'altro, non si racconta bene, poiché resta tutto in superfice. Trucco e acconciatura ottimi, ma il film delude eccome nonostante le 8 nomination agli Oscar 2023.
Black Panther: Wakanda Forever
Uno dei migliori film della fase 4 targata MCU è candidato a 3 premi oscar: attrice non protagonista, costumi e canzone originale firmata Rihanna. Insomma, le componenti per far bene c'erano e nel rispetto del lutto per Chadwick Boseman, che nei silenzi viene ricordato. La vita reale influenza quella di finzione, e Black Panther scompare così come il suo attore; Shuri, sorellina che in questo film cresce incarnando lo spirito del fratello, diventa la nuova supereroina.
Il film ha una sua identità e resta costante presentando anche un villain interessante e anarchico, frutto della dominazione coloniale. L'altra faccia del Wakanda, sfida il Wakanda: lo scontro è geopolitico, il vibranio è la risorsa energetica principale e lo stato africano deve preservarlo nonostante le altre nazioni provino a sottrarglielo con la forza.
The Batman
Due nomination per l'uomo pipistrello diretto da Matt Reeves ed interpretato da Robert Pattinson. Qui è Batman a divorare l'altra faccia, vale a dire Bruce Wayne. La rabbia, la paura, sono le emozioni iniziali vissute dal protagonista ma gradualmente tramutatesi in speranza e lucidità, grazie alle relazioni imbastite con Alfred e Selina.
Il male viene sconfitto, ma non muore mai. Lo sguardo nell'icona di Batman ha sempre un peso specifico, a maggior ragione in questa detective story intinta di noir e cinecomic: la grande metropoli, la pioggia perenne, la malinconia e l'amarezza a travolgere il detective protagonista in un conflitto interiore. L'azione contro la criminalità è convincente, pulita, esaltante per mano del regista particolarmente ispirato.
Top Gun: Maverick
Un film puramente classico, ma essenziale nella sua semplicità d'azione ed emotiva. Tom Cruise salva l'industria sfondando la porta del miliardo al botteghino, divenendo un cult istantaneo. Hold my Hand è una canzone intensa e meravigliosamente interpretata da Lady Gaga, ma il cinema classico è qui presente nelle relazioni tra i personaggi, nell'azione perfettamente credibile e pulita nelle immagini. Il discorso tradizione-contemporaneità, cinema-televisione, pilota manuale-pilota automatico, è esaltante nella sua natura prettamente meta cinematografica, semplicemente vitale.
Gli spiriti dell'isola
Geniale e drammaturgica per quanto ricorda il teatro questa rappresentazione metaforica diretta da Martin McDonagh. Colin Farrell ed il resto del cast sono tutti candidati perché sono magnifici nell'interpretazione, accesi, ispirati, comici e malinconici nei toni e nell'espressività. La guerra sullo sfondo lascia comprendere la sua natura: un capriccio, quello tra cattolici e protestanti irlandesi, a causa di un matrimonio. La religione è il pretesto, lo spirito delle "banshees" è incarna corporalmente da un'ambigua anziana che sembra indurre i personaggi a fare ciò che dice, ma in realtà è caricata di parodia grottesca.
Una presenza ingombrante quanto essenziale per captare le sfaccettature degli abitanti dell'isola: la noia è un pretesto per i due protagonisti, Pa'draic e Colm, dato che quest'ultimo si sente invecchiato, prossimo alla morte e poco stimolato dall'ormai ex amico. Decide di dedicarsi alla musica per tentare di trovare l'immortalità. I tempi comici quasi no-sense trovano in realtà una quadra nel grottesco totale dell'opera, accentuata fino all'amaro finale. La presenza femminile è una colonna portante in quanto portatrice di valori.
Tàr
Film estremamente complesso dove i chiaroscuri della fotografia e delle conseguenti ombre, riflettono esteriormente il personaggio, la cui personalità è sottolineata anche da altri elementi: costumi e scenografie perennemente grigie, nere e bianche, i sentimenti interiori e "macchiati" di Lydia Tàr. Si comporta esattamente come un protagonista uomo al cinema, solitamente un gangster: flirta con altre donne, offende, si costruisce una gabbia composta da convinzioni personali alimentate dal proprio ego.
La paura di perdere la tormenta, e alla fine le colpe vengono a galla condannandola all'esilio. Cate Blanchett è qui presente al top della forma, in una delle migliori interpretazioni della sua incredibile carriera. L'attrice australiana fa un lavoro maniacale sui gesti, le espressioni, i toni e gli sguardi. Una riflessione anche sull'industria contemporanea in dialogo con i social, la vita privata degli artisti che viene fuori e il pubblico, la critica e i media li cancellano come se nulla fosse.
Avatar: La Via dell'Acqua
In realtà uno dei film più snobbati (appena 4 nomination) è uno dei più belli in assoluti. James Cameron torna dopo più di un decennio dal primo capitolo e realizza un sequel fenomenale per la realizzazione tecnica unica, una scrittura semplice dove le immagini parlano più di quanto non facciano i dialoghi. L'empatia con la natura, la potenza delle figure femminili (una di esse è anche simbolo cristologico), la scenografia magniloquente dove la flora e la fauna svolgono un lavoro fondamentale ai fini della narrazione per far comprendere allo spettatore il legame speciale con la tribù dell'acqua. In un'epoca dove tutto sta diventando liquido (digitale), affrontare tale discorso in rapporto all'umanità sempre più cinica e avara, è un quid posto con intelligenza all'interno di questo meraviglioso sequel.
Tutti i personaggi, villain compreso, sono ampiamente sfaccettati ed offrono una tridimensionalità tale da ricordare perché è importante il confronto generazionale. Padri e figli si salvano a vicenda, ma i primi non ascoltano i secondo, almeno inizialmente. Il finale è una catarsi proprio per i genitori, che hanno portato una guerra coinvolgendo anche i figli e portando alla morte di uno di loro. Il diverso deve essere accettato, e in Avatar è presente in varie declinazioni: generazioni a confronto, rapporto uomo-natura, emarginazione sociale ed emigrazione. Le differenze fisiche delle due tribù, così come di Spider, soprannome per indicare il ragazzo umano qui presente, sono soltanto inizialmente viste come un ostacolo, poi le barriere si abbassano.
The Fabelmans
Il primo in classifica non può che essere un maestro assoluto: Steven Spielberg, candidato agli oscar in cinque decenni diversi nei cinquant'anni di attività. Meriterebbe di vincere almeno la regia, se non il film, ma questa è un'altra storia. Nell'epoca del convenzionale, tra biopic e autobiografie logorroiche, posticce e artificiose, dove gli autori si servono in realtà di loro stessi per raccontare il cinema e autocelebrarsi, Spielberg con grande umiltà utilizza il linguaggio cinematografico traendo spunto dalla sua vita elargendo una sconfinata passione, oltre che una consapevole finalità artistica. The Fabelmans parla di cinema con il cinema, riflettendo sull'immagine in quanto tale, mezzo unico per filtrare la realtà, ma finisce per influenzare la vita del giovane Spielberg, qui interpretato da Gabriel LaBelle.
Fin da qui si vede quanto il regista sia umile, lasciando l'attore libero di intingere al personaggio una propria personalità, senza forzarlo a fare un mero copia e incolla. Il cinema di Spielberg è essenziale, così come coloro che hanno lavorato al film e con lui prima, da tutta una vita: Janusz Kamiński (direttore della fotografia) e il famoso compositore John Williams. La crisi familiare è portata da una ripresa effettuata dal protagonista, intento a scoprire l'amore della sua vita, ossia il cinema (l'immagine influenza il reale). Dialogo con il nonno, Boris Schildkraut, semplicemente magnifico per la potenza e la caratura di Hirsch, grandissimo attore. Spielberg non si risparmia dal parlare del sogno americano e della sua intolleranza nei confronti dell'altro. Il finale è una chicca: Lynch interpreta Ford parlando a Spielberg dell'orizzonte nei film. Una lettera d'amore per il cinema, "scritta" con il cinema invece che a penna.
Articolo Precedente
ADG 2023: tutti i vincitori
Articolo Successivo
Bafta 2023: chi trionferà? Le predizioni
Articoli Correlati

Oscar 2023: previsioni e tanto altro
11/03/2023

I migliori 10 film sentimentali di sempre
06/03/2023

